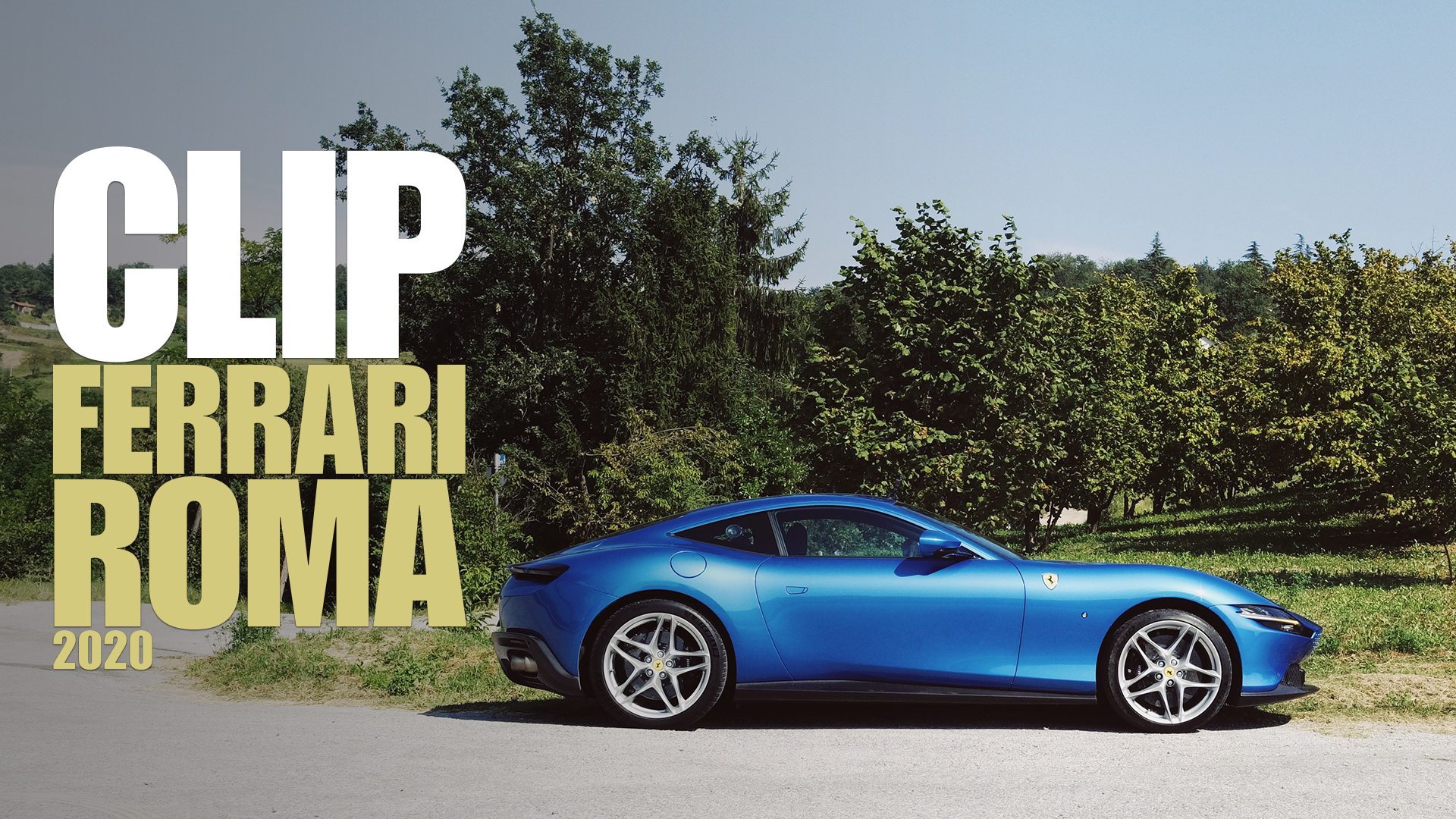I dazi rischiano di bloccare la produzione di auto anche negli USA
Secondo gli addetti ai lavori, la nuove tariffe del 25% applicate dagli USA ai prodotti canadesi e messicani metteranno in difficoltà anche la produzione statunitense.
LA PRODUZIONE SI FERMERÀ? - La questione dazi, che gli Stati Uniti imporranno sui beni provenienti da Canada e Messico (ma stando a quanto promesso arriveranno presto anche nei confronti di quelli europei), sta tenendo con il fiato sospeso tutto il settore automobilistico mondiale. Le nuove tariffe entreranno in vigore da domani (ma sono state sospese per un mese in attesa di ulteriori negoziati), passando dal 10 al 25%, e secondo molti analisti rischiano di bloccare la produzione di auto e di componenti non solo in Canada e in Messico, ma anche all’interno degli Stati Uniti stessi. “Chi si farà carico dei margini ridotti?”, si chiedono gli addetti al settore, prospettando una decisione drastica nel giro di una settimana: fermare le linee di produzione, con un conseguente rapido azzeramento del lavoro anche per l’intera filiera produttiva, compresa quella statunitense.
AUMENTERANNO I PREZZI - I dazi “avranno immediati impatti negativi sui posti di lavoro e sui consumatori”, ha detto David Adams, ceo della Global Automakers of Canada, che rappresenta i marchi d’importazione nel Paese, confermando che i produttori potrebbero trovarsi in una situazione “in cui le opzioni sono relativamente limitate”. In Canada costruiscono veicoli Ford, General Motors, Honda, Stellantis e Toyota. Secondo Brian Kingston, ceo della Canadian Vehicle Manufacturers’ Association, i dazi ridurranno la produzione di veicoli in tutto il Nord America, aumentando i prezzi e causando perdite di posti di lavoro negli stabilimenti in tutto il continente.
PERDITA DI COMPETITIVITÀ - Spostandosi verso sud, è il Gruppo Volkswagen tra i più preoccupati per i nuovi dazi sulla produzione del Messico: qui il costruttore tedesco ha uno dei suoi più grandi stabilimenti, a Puebla, dove nel 2023 sono state prodotte circa 350.000 vetture destinate all’esportazione negli USA. “Stiamo valutando tutti i potenziali effetti sull’industria automobilistica e sulla nostra azienda”, ha fatto sapere la Volkswagen con un comunicato. Dall’analisi della banca d’investimento Stifel, i dazi renderebbero non più competitive il 65% delle auto prodotte dal gruppo Volkswagen negli Stati Uniti, con pesanti ripercussioni anche sui posti di lavoro in Germania e in Europa.

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso